Noi siamo natura: una prospettiva medica sul legame tra ambiente e salute
Un viaggio tra fisiologia, neuroscienze e prevenzione, raccontato da Serena Campa, Medico Radiologo e Socia Fondatrice dell’Accademia Italiana di Biofilia (AIB)

a cura di Serena Campa
Medico Radiologo e Ambientale, Socia Fondatrice Accademia Italiana di Biofilia (AIB)
“Sapete, io non capisco come si possa passare accanto a un albero e non essere felici di vederlo”
(F. Dostoevskij, L’idiota)
Dostoevskij aveva perfettamente ragione. Ciascuno di noi avrebbe ottime ragioni per sentirsi felice nel vedere un albero: non solo per la sua bellezza e per la gioia che ci regala con la sua maestosa presenza, ma anche perché, in quel momento, sta contribuendo a migliorare la nostra salute. Da diversi anni, la ricerca scientifica ha rivolto crescente attenzione al legame tra l’esposizione a contesti naturali — in particolare ambienti boschivi — e la salute umana, dimostrandone i benefici. La nostra salute, infatti, è il risultato dell’interazione tra numerosi fattori, alcuni legati alla persona, altri esterni e indipendenti. Questi sono noti come determinanti di salute.
I determinanti possono essere distinti in:
• prossimali, cioè fattori individuali non modificabili (come età, sesso, predisposizione genetica);
• distali, più slegati dalla sfera personale, ma in parte modificabili (stili di vita, relazioni sociali, condizioni socio-economiche, culturali e ambientali).
Basti pensare all’impatto sulla salute pubblica di comportamenti non salutari, come una dieta scorretta o l’abuso di alcool e fumo. Un ulteriore esempio è rappresentato dalla mobilità globale: negli ultimi decenni si è verificato un rapido incremento degli spostamenti di persone e merci, con una conseguente accelerazione nella diffusione di molte malattie infettive. Non da ultimo, il ruolo dell’ambiente è cruciale nel determinare lo stato di salute delle popolazioni, attraverso le sue componenti chimiche, biologiche e fisiche, che interagiscono costantemente con l’organismo umano.

È tristemente noto come, a partire dalla Rivoluzione Industriale, l’impatto delle attività umane sull’ambiente sia diventato sempre più gravoso, fino a caratterizzare l’attuale periodo storico, ribattezzato Antropocene: una nuova epoca geologica segnata dagli effetti ormai irreversibili dell’inquinamento e della pressione antropica sugli ecosistemi.
Le conseguenze di tali alterazioni si riflettono sulla salute umana in diversi modi:
• effetti diretti, come lo stress da calore, i carcinomi cutanei o gli impatti delle inondazioni;
• effetti indiretti, più lenti ma altrettanto rilevanti, dovuti alla progressiva compromissione degli ecosistemi (come la diffusione di malattie o la ridotta disponibilità di acqua potabile e cibo).

Se è vero che vivere in un ambiente alterato può rappresentare un rischio per la salute, è altrettanto vero che l’interazione con un ambiente sano può generare numerosi benefici, su diversi livelli. Su questa interazione si concentra da tempo la letteratura scientifica, con un numero crescente di evidenze a conferma dell’importanza dell’esposizione a contesti naturali per il nostro benessere psicofisico. È bene sottolineare che si tratta di effetti prevalentemente preventivi e di supporto terapeutico: validi per promuovere la salute nei soggetti sani e per affiancare, ma non sostituire, le terapie farmacologiche nei pazienti con patologie.
Dal punto di vista fisiologico, i principali benefici osservati riguardano:
• il sistema immunitario;
• l’apparato cardiovascolare;
• l’apparato respiratorio.
SISTEMA IMMUNITARIO
Uno dei pionieri della ricerca in questo ambito è stato l’immunologo giapponese Qing Li, figura di riferimento e promotore dello sviluppo della medicina forestale in Estremo Oriente. Le sue ricerche si sono concentrate principalmente sulla risposta delle cellule Natural Killer (NK) – linfociti del sistema immunitario deputati al riconoscimento e alla distruzione di cellule tumorali o infettate da virus – all’esposizione a fattori di derivazione forestale, in particolare ai fitocidi, oli essenziali volatili rilasciati dagli alberi nell’atmosfera. Li ha dimostrato che, dopo l’esposizione, si registra un incremento dei livelli intracellulari di molecole chiave per l’attività citotossica di questa classe di linfociti. In seguito ai primi studi di Li, la ricerca sugli effetti immunitari dell’esposizione alla natura ha conosciuto un notevole sviluppo.
I dati più ricorrenti rilevano:
• un aumento del numero e dell’attività delle cellule NK, con conseguente potenziamento delle difese antivirali e antitumorali;
• un riequilibrio dei livelli ematici di citochine, gruppo di proteine che include mediatori pro- e anti-infiammatori.
Questi effetti si traducono in una riduzione dello stato infiammatorio cronico, con un impatto preventivo importante rispetto a molte condizioni patologiche in cui l’infiammazione rappresenta uno step chiave della progressione clinica, come: malattie cardiovascolari, patologie autoimmuni, malattie neurodegenerative, e tumori.
La funzione immunitaria risulta ulteriormente sostenuta anche da altri meccanismi:
• La presenza di ioni negativi, abbondanti in ambienti naturali;
• L’interazione con i microrganismi presenti sugli alberi, nel suolo, nell’aria e nell’acqua, che influenzano positivamente il nostro microbiota (cutaneo, intestinale e respiratorio), contribuendo all’omeostasi immunitaria complessiva.
APPARATO CARDIOVASCOLARE
Numerosi studi hanno valutato il ruolo degli ambienti naturali sulla salute umana, concentrandosi in particolare sull’apparato cardiovascolare, sia in soggetti sani che in adulti o anziani con patologie preesistenti, come l’ipertensione. Uno studio condotto su 24 pazienti anziani affetti da ipertensione essenziale, suddivisi per sette giorni in due gruppi – uno esposto a un ambiente forestale e l’altro a un ambiente urbano di controllo – ha evidenziato, nel gruppo immerso nel contesto naturale, una significativa riduzione dei valori della pressione arteriosa e dei livelli ematici di diversi biomarcatori coinvolti nella regolazione della pressione, come quelli del sistema renina–angiotensina–angiotensinogeno, oltre che di citochine pro-infiammatorie come interleuchina-6 (IL-6) e TNF-alfa. Molti altri studi hanno confermato questi risultati, riportando una diminuzione della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca dopo l’esposizione a contesti forestali.
Il rischio cardiovascolare globale – così come i livelli di infiammazione cronica – appare inoltre ridotto in relazione agli effetti positivi sia sul metabolismo sia sul sistema neuroendocrino. Sono stati infatti osservati:
• Una diminuzione dei livelli ematici, salivari e urinari di trigliceridi e glucosio, con conseguente miglioramento del profilo metabolico;
• Una riduzione dei livelli di cortisolo e delle catecolamine (adrenalina e noradrenalina), ormoni coinvolti nelle risposte acute allo stress;
• Un incremento di molecole a funzione cardio-protettiva, a conferma del ruolo rigenerativo degli ambienti naturali anche sul piano ormonale e infiammatorio.
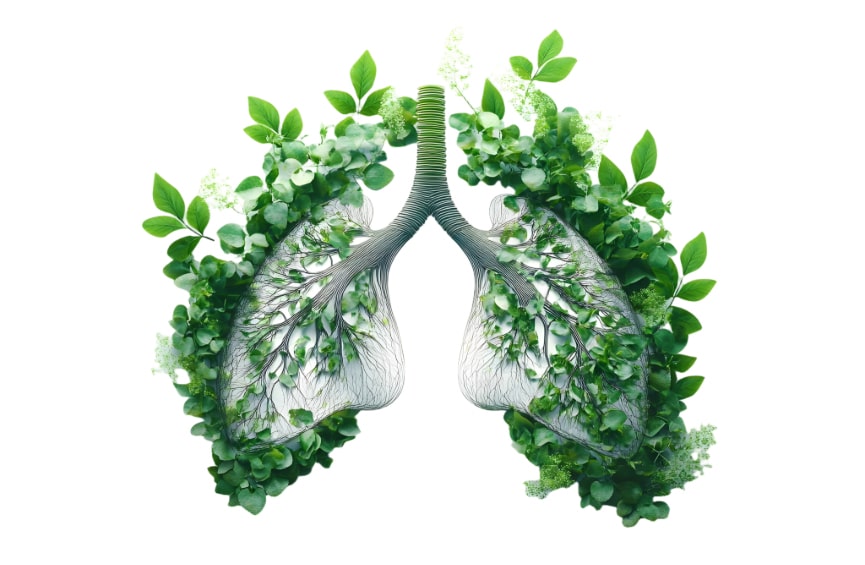
APPARATO RESPIRATORIO E PATOLOGIE A GENESI ALLERGICA
Anche l’apparato respiratorio e le patologie a base allergica traggono beneficio dall’esposizione a contesti naturali. In Finlandia, per esempio, sono stati attivati diversi studi e programmi governativi – tra cui il Finnish Allergy Programme 2008-2018 e il Finnish Asthma Programme 1994-2004 – con l’obiettivo di monitorare l’impatto sociale ed economico di patologie croniche come asma e allergie. Tali ricerche hanno evidenziato il ruolo dell’ambiente urbano nella genesi di queste malattie, in particolare per l’esposizione a inquinanti atmosferici, fattori occupazionali, o, al contrario, per la mancanza di contatto con microrganismi benefici presenti nel suolo, fondamentali per il corretto sviluppo e mantenimento dell’omeostasi immunitaria.
Studi condotti in Corea del Sud hanno messo in luce l’influenza dell’urbanizzazione sulla comparsa di patologie immuno-mediate. In particolare, è stato valutato il ruolo terapeutico delle immersioni forestali in due gruppi di bambini, affetti rispettivamente da asma e dermatite atopica: condizioni differenti, ma accomunate da una disfunzione della risposta immunitaria. I risultati hanno indicato un effetto favorevole dell’ambiente naturale sulla regolazione immunitaria in entrambi i casi.
Un meccanismo simile è stato rilevato anche nella Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), una patologia respiratoria diffusa e invalidante, causata principalmente dal fumo di sigaretta o dall’esposizione a inquinanti ambientali. La BPCO si manifesta con bronchite cronica e infiammazione persistente, che nel tempo può evolvere in enfisema, ovvero la distruzione progressiva degli alveoli polmonari, le unità responsabili degli scambi gassosi tra aria e sangue. Questo determina una ridotta ossigenazione, con conseguente sofferenza per tutti i distretti corporei.
Uno studio condotto su pazienti con BPCO, suddivisi in due gruppi (uno esposto a un ambiente forestale e l’altro a un ambiente urbano), ha dimostrato che il gruppo immerso nella foresta presentava una significativa riduzione dei livelli sierici di citochine e altri marcatori pro-infiammatori in diverse popolazioni linfocitarie. Questo si è tradotto in una complessiva attenuazione dello stato infiammatorio sistemico, con potenziali implicazioni terapeutiche.

SISTEMA NERVOSO CENTRALE E FUNZIONI PSICO-COGNITIVE
Trascorrere del tempo nella Natura non è solo un toccasana per il nostro organismo, ma anche per l’umore e il benessere mentale, sempre più messi alla prova dalla società della performance e dell’iperconnessione. Un ruolo fondamentale, infatti, è svolto dall’esposizione agli ambienti naturali nel promuovere i nostri livelli di benessere psico-cognitivo.
Uno dei primi studiosi a intuire il potenziale benefico della Natura fu Roger Ulrich, architetto e padre dell’Healthcare Design. Nel 1981 dimostrò che, sottoponendo soggetti alla visione di immagini di ambienti naturali rispetto a contesti urbani, si otteneva una riduzione della frequenza cardiaca e un aumento dell’ampiezza delle onde alpha nell’elettroencefalogramma, indicativo di uno stato di rilassamento. Nel 1984, Ulrich condusse un ulteriore studio su pazienti ospedalizzati: coloro che soggiornavano in stanze con vista su ambienti naturali presentavano un decorso post-operatorio migliore rispetto a chi aveva la vista su un muro. I benefici osservati includevano una riduzione della durata dell’ospedalizzazione, un minor numero di complicanze durante la convalescenza e un minor utilizzo di farmaci analgesici. Numerose ricerche più recenti hanno confermato ciò che Ulrich aveva già intuito: il contatto con la natura induce uno stato di rilassamento cerebrale misurabile.
Studi hanno evidenziato, per esempio, che una passeggiata nel bosco o attività di giardinaggio provocano una riduzione dell’attività neuronale in alcune aree cerebrali, rilevata tramite i livelli di ossigenazione sanguigna, in particolare nella corteccia prefrontale, regione chiave per le funzioni cognitive superiori. Anche stimoli olfattivi legati a componenti arboree – come trucioli di cedro, ciliegio, foglie di cipresso o α-pinene – sembrano attivare risposte neurofisiologiche simili. Studi basati su Risonanza Magnetica Funzionale hanno dimostrato che, dopo una passeggiata di 90 minuti in un contesto naturale, si verifica una diminuzione dell’attività in aree encefaliche associate a emozioni negative come tristezza, paura, senso di minaccia e stress. Ne risulta un generale miglioramento dell’umore e una condizione neuropsicologica più distesa.

Una correlazione negativa è stata inoltre osservata tra la crescita in ambienti urbani e il volume di sostanza grigia in aree del cervello coinvolte nel controllo cognitivo e nella regolazione dello stress. Questo suggerisce che vivere in ambienti rurali, soprattutto nei primi anni di vita, possa rappresentare un fattore protettivo a livello neuroevolutivo. Ulteriori studi si sono concentrati sull’attivazione del circuito della gratificazione, spesso compromesso nei disturbi depressivi. Il contatto con la Natura sembra riattivare tali circuiti, contribuendo a effetti antidepressivi. Inoltre, queste stesse aree cerebrali influenzano positivamente memoria e funzione cognitiva, potenziandole. Un altro elemento rilevante è la luce naturale. È stato dimostrato che una maggiore esposizione alla luce solare favorisce una più rapida sintesi di serotonina, neurotrasmettitore cruciale nella regolazione dell’umore e delle emozioni. Questo effetto è mediato sia dalla stimolazione delle cellule retiniche, sia dalla produzione di vitamina D nella cute. Gli ambienti naturali si rivelano essenziali anche per un’altra funzione cognitiva chiave: la rigenerazione dell’attenzione.
Secondo la teoria formulata da William James nel 1892, l’attenzione può essere suddivisa in due componenti:
• involontaria (o fascinazione), attivata spontaneamente da stimoli ambientali, senza sforzo cognitivo;
• volontaria, che richiede controllo attivo ed è impiegata nelle attività che richiedono concentrazione.
Sulla base di questa distinzione, i coniugi Rachel e Stephen Kaplan hanno sviluppato, negli anni ’80, la Teoria della Rigenerazione dell’Attenzione. Secondo questo modello, l’esposizione alla natura – grazie all’attivazione piacevole e soft dell’attenzione involontaria – permette una pausa per l’attenzione volontaria, favorendone la rigenerazione e il ripristino delle capacità cognitive. Uno studio statunitense dei primi anni 2000, condotto presso l’Università del Michigan, ha applicato questo principio a due gruppi di studenti, sottoposti a test neuropsicologici dopo una passeggiata in un parco o dopo l’osservazione di immagini di paesaggi naturali. In entrambi i casi, si è osservato un miglioramento delle funzioni esecutive e delle performance cognitive, anche dopo una semplice esposizione visiva alla natura.
IMMERSIONI FORESTALI E HEALING GARDENS
Il crescente riconoscimento dei benefici legati al tempo trascorso in contesti naturali, unito all’interesse crescente per questi temi, ha spinto diversi Paesi ed enti a promuovere sessioni di riconnessione con la natura e attività pensate per offrire tali benefici su larga scala. Le cosiddette “terapie forestali” sono state definite come “attività in grado di migliorare lo stato di salute, prevenire numerose malattie e rafforzare il sistema immunitario, grazie a diverse componenti dell’ambiente forestale”. Si tratta di una forma di intervento a basso costo, sicura e priva di effetti collaterali.
Uno dei primi Paesi a sviluppare sistematicamente il concetto di benessere associato alla foresta è stato il Giappone, dove oltre il 66% del territorio è coperto da aree boschive, da sempre considerate luoghi sacri, dimora di divinità. Nel 1982, il direttore dell’Agenzia Forestale Giapponese, Tomohide Akiyama, coniò il termine Shinrin-Yoku, letteralmente forest bathing o “bagno di foresta”: una pratica di immersione nella natura che, attraverso l’attivazione consapevole dei cinque sensi, favorisce uno stato profondo di benessere. Grazie alla promozione istituzionale, il forest bathing divenne rapidamente diffuso tra la popolazione, stimolando anche lo sviluppo della ricerca scientifica in materia.
Inizialmente gli studi si concentrarono su caratteristiche ambientali come:
• la presenza di fitocidi (oli essenziali rilasciati dalle piante);
• la concentrazione di ioni negativi;
• i servizi ecosistemici offerti dalle foreste (purificazione e conservazione dell’acqua, regolazione del clima, ecc.).
In seguito, l’attenzione si è spostata sugli effetti diretti sulla salute umana, tra cui:
• riduzione dei livelli di cortisolo;
• abbassamento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca;
• miglioramento di sintomi legati a ansia, depressione e stress.
Gli studi condotti dal già citato Qing Li, in particolare quelli sulla funzione immunitaria e sulla correlazione tra copertura forestale e ridotta mortalità tumorale, insieme a una crescente produzione scientifica di qualità, hanno portato nel 2008 alla nascita della Società Giapponese di Terapia Forestale.
I suoi obiettivi includono:
• la diffusione delle evidenze scientifiche;
• la formazione di professionisti specializzati;
• la certificazione di foreste terapeutiche.
Anche in Cina sono state avviate politiche dedicate alla promozione del benessere forestale, con la creazione di aree certificate destinate a tali attività. L’Occidente non è rimasto indietro. La già citata Finlandia, attraverso programmi nazionali come il Finnish Allergy Programme e il Finnish Asthma Programme, ha dimostrato l’importanza della natura nella prevenzione e nella gestione di patologie croniche a genesi immuno-allergica. Il Regno Unito ha attivato numerose iniziative pubbliche e private volte a incentivare la fruizione degli spazi forestali da parte della cittadinanza, con un forte supporto governativo a pratiche di forest bathing e green prescriptions.
Anche Canada e Nuova Zelanda rappresentano modelli d’avanguardia: in entrambi i Paesi, sono stati implementati programmi nazionali di prescrizione della natura, dove i professionisti sanitari possono “prescrivere” la frequentazione di ambienti naturali alla stregua di un trattamento medico. Gli effetti del forest bathing risultano massimizzati in ambienti ad alta biodiversità, come le foreste vetuste, ma questi ecosistemi sono ormai rari nei nostri territori. È quindi fondamentale garantire accessibilità e fruibilità degli spazi verdi: se vogliamo rendere i benefici della natura disponibili a tutti, è necessario disporre di luoghi vicini, sicuri e inclusivi, anche in ambito urbano.
Un altro fattore rilevante è il grado di biofilia delle persone. Chi è stato a lungo disabituato al contatto con la natura può sperimentare forme di biofobia: disagio, ansia o timore in ambienti percepiti come troppo “selvatici” (paura di insetti, spazi chiusi, terreni non controllabili). Questo può ridurre l’efficacia dell’esperienza naturale. Occorre inoltre considerare le condizioni fisiche e cliniche dei partecipanti: un paziente con difficoltà motorie, come una persona affetta da morbo di Parkinson, potrebbe essere esposto a rischi in ambienti con fondo irregolare o ostacoli naturali. Proprio per questo, anche parchi pubblici e aree verdi urbane devono essere considerati infrastrutture fondamentali per la salute pubblica e dovrebbero essere integrati pienamente nella pianificazione delle città.
Quanto tempo serve per ottenere benefici? La maggior parte degli studi concorda sulla soglia minima di due ore settimanali trascorse in ambienti naturali. Anche sessioni brevi – da 15 a 20 minuti –possono generare effetti significativi, soprattutto in termini di riduzione di ansia e stress. Ma il benessere legato alla natura non si limita alle passeggiate nei boschi: anche il giardinaggio e la cura del verde offrono vantaggi misurabili. Le pratiche di ortoterapia si sono rivelate utili in molti contesti terapeutici: per pazienti affetti da patologie neurodegenerative (come Parkinson e Alzheimer); per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico.
In Italia esistono già diversi esempi virtuosi di giardini terapeutici integrati nelle strutture sanitarie, , come, per citarne alcuni, l’Ospedale San Camillo di Roma; l’Ospedale Meyer di Firenze; il Policlinico di Milano, dove è in corso la realizzazione di un nuovo padiglione che ospiterà un giardino pensile grande quanto un campo da calcio e un progetto di riqualificazione verde delle aree tra i padiglioni.

VERSO UNA MEDICINA INTEGRATA CON L’AMBIENTE
La Natura non è solo un contesto piacevole, ma un vero e proprio agente attivo di prevenzione, regolazione e supporto terapeutico. In un momento storico segnato da stress cronico, disconnessione e vulnerabilità collettiva, riscoprire il valore clinico dell’esposizione alla Natura non è una suggestione romantica: è una necessità. La medicina ambientale ci invita a integrare ambiente, salute e scelte quotidiane in un’unica visione di cura. Perché noi siamo Natura, e solo riconoscendoci come parte di essa potremo prenderci davvero cura di noi stessi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



