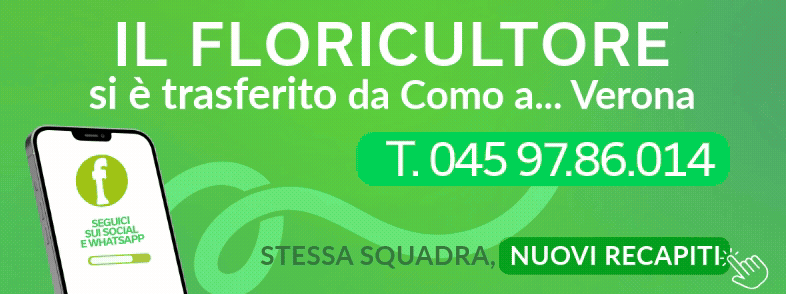Il futuro è biofilico: nuove prospettive per chi progetta e cura il verde
Norme, certificazioni e nuove competenze stanno trasformando la connessione tra natura e progettazione, spiega l’Accademia Italiana di Biofilia nel nuovo appuntamento web con i nostri lettori. Un’evoluzione che apre prospettive significative per tutti i professionisti del verde

a cura di Alice Piovan
Architetta, Biophilic Designer, esperta presso Accademia Italiana di Biofilia (AIB)
Viviamo in un’epoca in cui la sola sostenibilità, intesa nella sua definizione classica, non è più sufficiente. Nella versione più nota – quella del Rapporto "Our Common Future" (Rapporto Brundtland, 1987), elaborato dalla Commissione mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite – lo sviluppo sostenibile è «la capacità di soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri». A quasi quarant’anni di distanza, questa definizione si è evoluta per rispondere a sfide sempre più complesse: non basta preservare ciò che resta, occorre rigenerare ciò che è stato compromesso. Oggi si parla sempre più di rigenerazione: un approccio attivo che ripara, rafforza e reintegra la natura negli spazi di vita e di lavoro, restituendo benefici ambientali, sociali, economici e sanitari.
Questo cambio di prospettiva ci porta verso una visione meno antropocentrica e più ecosistemica, in cui l’essere umano è parte di una rete di vita e non il centro assoluto. In questa direzione, uno degli strumenti più efficaci è il Biophilic Design: un approccio progettuale e strategico, fondato su solide basi scientifiche, che integra elementi e processi naturali negli spazi costruiti per generare benessere psicofisico, migliorare le prestazioni cognitive, favorire la socialità e restituire valore ecologico agli ambienti. A differenza di interventi puramente estetici, il Biophilic Design lavora con un sistema di strategie che guidano progettisti, tecnici e stakeholder nella creazione di spazi realmente connessi alla natura. Interventi che, se ben pensati, possono ridurre lo stress, migliorare il comfort termico e visivo e rafforzare il senso di appartenenza a un luogo – con benefici che si manifestano già nel breve periodo.
Per questo motivo, sistemi di certificazione e politiche europee e italiane stanno riconoscendo e promuovendo sempre più la connessione uomo-natura come leva per il benessere e lo sviluppo rigenerativo. Non si tratta più di un’opzione accessoria, ma di un elemento imprescindibile della vita quotidiana e della qualità degli spazi. E per i professionisti del verde – florovivaisti, paesaggisti, manutentori, tecnici e operatori – questo significa un nuovo orizzonte professionale, in cui il proprio know-how diventa decisivo per rispettare standard emergenti e partecipare attivamente alla trasformazione del nostro ambiente costruito.
CERTIFICAZIONI E STANDARD: DAL CONCETTO ALLA PRATICA
Nel settore dell’edilizia esistono sistemi di certificazione di sostenibilità che valutano gli edifici in base a criteri precisi: efficienza energetica, impatto ambientale, comfort e salute per le persone. Alcuni dei più diffusi a livello internazionale sono LEED e WELL. In passato, questi sistemi si concentravano soprattutto su aspetti come efficienza energetica e prestazioni tecniche. Oggi, invece, includono sempre più spesso anche i principi del Biophilic Design, cioè strategie progettuali che integrano la natura negli spazi interni ed esterni.
In pratica, significa che, per ottenere queste certificazioni, un progetto deve dimostrare di offrire spazi verdi accessibili, elementi naturali all’interno, luce naturale di qualità e ambienti che favoriscano il benessere fisico e mentale. Tra i criteri di valutazione, il Biophilic Design ha conquistato un posto di rilievo, perché si è capito che la qualità di un edificio o di un’area non si misura solo in kWh risparmiati, ma anche in quanto e come la natura è presente e fruibile. Non tutti i professionisti del verde hanno familiarità con questi strumenti, ma sono sempre più richiesti in gare d’appalto, progetti pubblici e interventi privati di qualità. Conoscerli significa capire dove e come il proprio lavoro può essere valorizzato.
LEED - LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN
È uno dei sistemi di certificazione ambientale più diffusi al mondo. Nella sua ultima versione, sottolinea che «strategie come il design inclusivo e il Biophilic Design, che mettono in connessione le persone con la natura, riducono lo stress, migliorano la qualità dell’aria e potenziano le prestazioni cognitive». In concreto, per ottenere punti LEED è necessario, ad esempio: prevedere spazi esterni accessibili con habitat biodiversi che includano elementi che favoriscono l’interazione umana con la natura; inserire elementi e pattern biofilici negli interni, come richiesto dal credito “Esperienza dell’utente” nella categoria Qualità dell’Ambiente Interno.
WELL BUILDING STANDARD
È uno standard che misura la qualità di vita e il benessere negli edifici. Fin dalle prime versioni ha inserito la Biofilia come principio guida, indicando azioni precise: organizzare attività che connettano le persone con gli elementi naturali; garantire una buona esposizione alla luce naturale; usare elementi biofilici (piante, materiali naturali, forme e colori ispirati alla natura) nelle aree comuni; assicurare a tutti una connessione visiva e fisica con la natura.
LIVING BUILDING CHALLENGE
È uno dei protocolli più avanzati in termini di sostenibilità e richiede un approccio molto completo. Dedica alla Biofilia un intero “imperativo”: fin dalle prime fasi di lavoro, il team di progetto deve partecipare a un workshop biofilico per capire come integrare la natura nel progetto, identificare il “potenziale biofilico” dell’intervento e pianificare soluzioni che offrano benefici concreti agli utenti finali.
NORMATIVE E INIZIATIVE EUROPEE: LA BIOFILIA OLTRE I PROTOCOLLI
Accanto ai sistemi che citano esplicitamente la Biofilia e il Biophilic Design, esistono normative nazionali e iniziative europee che, pur non utilizzando sempre questa terminologia, promuovono sostanzialmente gli stessi principi: connessione profonda con la natura, tutela degli ecosistemi e miglioramento della qualità della vita. Un esempio chiave è rappresentato dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia, che introducono requisiti specifici come:
• Quantità e qualità della luce naturale interna;
• Valutazione dello stato delle componenti ambientali del sito;
• Protezione e manutenzione della vegetazione esterna di pertinenza.
Un altro ambito strategico è quello delle Nature-Based Solutions (NbS) – soluzioni ispirate e supportate dalla natura che promuovono l’uso sostenibile delle risorse naturali per affrontare sfide ambientali e sociali, dalla mitigazione climatica alla salute urbana. Le NbS sono centrali in politiche come il Green Deal europeo e la EU Biodiversity Strategy for 2030, e possono contare su numerosi strumenti di finanziamento, tra cui Horizon Europe, LIFE e Biodiversa+. In sintesi, una progettazione attenta alla natura – alle sue forme, ai suoi processi e alle relazioni che intreccia con l’uomo – non è più solo auspicabile: oggi è esplicitamente incoraggiata e sostenuta sia in ambito privato sia nelle politiche pubbliche. Per i professionisti del verde, questo significa operare in un contesto normativo che riconosce e valorizza il loro ruolo nella transizione ecologica.

OPPORTUNITÀ CONCRETE PER IL SETTORE DEL VERDE
Questa evoluzione apre prospettive significative per chi opera nel mondo del verde. Le competenze richieste spaziano dalla consulenza botanica e climatica – per scegliere specie vegetali resilienti al cambiamento climatico e adatte alle specifiche condizioni di luce, suolo e acqua – alla progettazione funzionale di spazi che non solo abbelliscono, ma contribuiscono a mitigare l’isola di calore urbana, migliorare la biodiversità, filtrare l’aria e ridurre il rumore. Un ruolo sempre più strategico è quello legato alla manutenzione ad alte prestazioni: la cura di pareti e tetti verdi, cortili biodiversi e aree comuni in grado di garantire elevate performance in ogni stagione dell’anno. Sarà inoltre fondamentale promuovere un approccio multidisciplinare, in cui professionisti del verde, progettisti e tecnici collaborino fin dalle prime fasi, rafforzando il dialogo tra natura e architettura.

DAL PROGETTO ALLA CULTURA DIFFUSA
Il Biophilic Design non è solo un insieme di strategie, ma una cultura progettuale che mette la vita al centro in ogni scelta. Significa passare da una visione in cui la natura è un ornamento a una visione in cui è un’infrastruttura viva, parte integrante di città, edifici e comunità. Chi lavora nel settore del verde ha oggi un ruolo strategico: è custode e promotore di questa transizione, con competenze che il mercato richiede sempre più e che le politiche pubbliche stanno attivamente sostenendo. Il futuro è già scritto nei sistemi di certificazione, nelle normative e nelle richieste dei committenti: si tratta di coglierlo, con la consapevolezza che progettare con la natura significa progettare il futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA